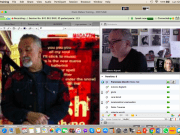20 anni senza Faber: è questo il titolo del concerto in programma sabato prossimo al Teatro Santa Giulia di Brescia. Sarà un tributo a Fabrizio De André con i Mercantinfiera 2.0 e con un ospite eccezionale: Mark Baldwin Harris.
Nato nel Connecticut nel 1955, Mark Baldwin Harris si è trasferito in Italia nel 1967 ed a lungo ha collaborato con Fabrizio De André. In carriera ha fatto parte dei Napoli Centrale e lavorato con tanti altri artisti importanti come Edoardo Bennato, Tony Esposito, Antonella Ruggiero, Laura Pausini, Sergio Caputo, Eros Ramazzotti, Giorgio Gaber, Skiantos, Massimo Riva, Mia Martini, Enzo Jannacci, Pino Daniele, Roberto Vecchioni, Claudio Chieffo, Eugenio Finardi e Renato Zero. Lo abbiamo intervistato.
Mark, cosa succederà il 6 aprile a Brescia?
Gli spettatori potranno vedere un concerto dei Mercantinfiera, un gruppo di Verona che da anni porta avanti un tributo a Fabrizio De André. Eccezionalmente, pregato dall’organizzatore che è un amico, ho accettato di suonare con loro in tre brani, più un bis finale. Sarà sicuramente una bella serata musicale.
Ha lavorato tanti anni con Fabrizio De André. Ricorda come è nata questa collaborazione?
Benissimo, perfettamente. Ci siamo conosciuti nel 1980, quando sono stato convocato dalla casa discografica Ricordi per suonare nella canzone Titti, il lato B del 45 giri Una storia sbagliata. In cd questa canzone è uscita per la prima volta solo nel 2005, nella raccolta In direzione ostinata e contraria. In quell’occasione abbiamo fatto amicizia e abbiamo parlato a lungo, ripromettendoci di rivederci in futuro.
Poi cosa è successo?
Qualche mese dopo Fabrizio De André mi ha chiamato a suonare nel disco di Massimo Bubola Tre rose, che stava producendo. Ho suonato il piano, ma anche arrangiato gli archi e le tastiere. De André era sempre più entusiasta e ad un certo punto mi ha chiesto: «Belin, ma tu conosci un po’ la musica sarda?». Caso vuole che io già da alcuni anni seguissi in maniera fanatica la musica sarda tradizionale e quindi ho risposto di sì, che era una mia passione. Poi mi ha chiesto se conoscessi l’Ave Maria sarda, accennando la versione che gli interessava. Era quella di una band di Oristano. Lo invitai a casa mia per fargli ascoltare le varie versioni dell’Ave Maria della Sardegna e in quell’occasione mi confermò che voleva fare proprio quella versione, “alla Pink Floyd”, con un coro tradizionale sardo.
Come si è ritrovato alla fine a cantare l’Ave Maria?
Siamo andati in Sardegna a fare le prove, ma i coristi facevano fatica. Per far capire loro dove entrare, cantavo la voce principale, notando che Fabrizio mi guardava un po’ sorpreso e incuriosito. Quando siamo andati a registrare il disco in Brianza, al Castello di Carimate, ho fatto la base e i vari “giochi” alla Pink Floyd. De André era entusiasta e gli ho chiesto quando sarebbe arrivato il coro. E lui mi ha risposto: «Belin, ma cantala te». Mi sono un po’ incavolato, perché se me lo avesse detto prima cambiavo la tonalità per cantare più agevolmente. Si è messo a ridere, dicendo semplicemente «mi piace quando sforzi così».
Perché a vent’anni dalla sua scomparsa il ricordo di De André è ancora così vivo?
In gran parte perché dopo non c’è stato più nessuno ad occupare quel tipo di posizione nell’offerta musicale. Cantautori ce ne sono tanti, ma che si fagocitano tra di loro, tutta roba riciclata. Non che Fabrizio fosse avverso a plagi o cose del genere, pescava dove pescava. Però faceva un disco ogni quattro o cinque anni non per pigrizia, ma perché aveva una visione molto superiore rispetto agli altri. Il suo era un approccio molto più ponderato, intellettuale, articolato e intelligente. E questo rimane. I suoi dischi rimangono, sono compiuti, sono belli. Era un perfezionista, se una cosa non gli piaceva la buttava via. Ha fatto impazzire tanti miei colleghi. A me però è andata benissimo, il nostro rapporto era molto positivo. Io non lo conoscevo prima di incontrarlo in sala di incisione, non ero intimidito da lui.
Come lo definirebbe?
Un grande interprete, cantante. Tutti dicono grande cantautore. Di pugno suo ha scritto forse cinque brani. Le altre canzoni sono scritte da altri, poi lui correggeva, facendole diventare migliori, aggiungendo una parola qua e una parola là. Per carità, nulla da togliere, ma era soprattutto un grande interprete. E poi il regista di se stesso, un autoproduttore con una visione interessante.
E’ arrivato in Italia nel 1967 e a metà degli anni ’70 si è ritrovato a far parte di Napoli Centrale. Che ricordi ha di quell’esperienza?
Erano fanatici della stessa musica che amavo io. Ho dei ricordi bellissimi. Abitavo a Positano, questo è già sufficiente a dire quanto fossero belli quegli anni. Andavamo in giro a fare le serate, una bella vita. Sarei rimasto volentieri là, però per lavoro mi chiamavano continuamente da Roma e Milano. Così ho iniziato a gravitare soprattutto su Milano, anche se all’inizio non mi piaceva molto. Solo anni dopo ho capito che quello milanese è lo spirito dell’austriaco mancato. Per diversi anni sono stato in albergo, mi rifiutavo di prendere un appartamento, a lungo ho tenuto la casa a Positano pensando di tornare giù.
Ha lavorato con tantissimi artisti. C’è una collaborazione che le è rimasta nel cuore in modo particolare?
Tante, sia con artisti molto famosi che meno conosciuti. Mi sono trovato quasi sempre bene, anche se qualche “testa di rapa” l’ho incontrata. Uno degli artisti con cui ho lavorato più a lungo è stato Enzo Jannacci. Cercavo sempre di liberarmi quando mi chiamava per i suoi tour, era un gran divertimento. Lavorava come cardiochirurgo, operava a cuore aperto bambini e neonati. Per lui le serate erano puro divertimento. Tanti altri artisti invece sono paranoici, prima di andare sul palco devono vomitare in bagno. Io se posso vado con quelli che si vogliono divertire, a parità di talento. A parte Jannacci, l’artista italiana con cui lavoro da più anni è Antonella Ruggiero. Suono con lei dal 2003, la nostra collaborazione è più lunga di quella sua con i Matia Bazar. Con lei mi trovo benissimo.
Come ha iniziato a fare musica?
Ho iniziato a prendere lezioni di piano quando avevo 7 anni. Avevo la passione per la musica già da piccolissimo e i miei genitori, dopo un anno che li tormentavo, hanno accettato di farmi prendere lezioni. La mia prima insegnante era bravissima, aveva 80 anni: il suo maestro di piano era stato un allievo americano di Franz Liszt.
Com’è cambiato il mondo della musica da quando lo frequenta da professionista?
Dal punto di vista lavorativo è cambiato radicalmente. Spesso, alla fine dei miei concerti, incontro ragazzi che mi definiscono “mito” per Napoli Centrale. E io non so se essere lusingato o depresso per questo. Ovviamente mi fa piacere che i giovani apprezzino quella musica, che amo ancora anche io. Ma è come se io alla loro età avessi ascoltato solo ragtime o cose degli anni ’30. Questi stessi ragazzi, a volte, mi chiedono com’era fare il turnista negli anni d’oro. E non mi credono quando rispondo che come tastierista facevo la base, poi ogni sovraincisione era un turno in più, dopo una certa ora scattava il doppio turno, che nel weekend magari era anche triplo o quadruplo. Gli sembra roba da fiabe.
Quest’anno ricorre anche il ventennale della morte di Massimo Riva. Lei ha collaborato anche con lui, ricorda in che occasione?
Sì, il disco era Matti come tutti. La canzone era Lui Luigi, versione di Louie Louie che Riva realizzò con Elio. All’epoca uno dei miei allievi iniziava la sua lunga collaborazione con Elio, era Antonello Aguzzi, il cosiddetto Jantoman. Aveva l’orecchio assoluto e un’ottima tecnica. L’ho spinto ad entrare nel giro, mettendolo a lavorare nella sala di incisione “Psycho” di Claudio Dentes. Così ha conosciuto Elio e le Storie Tese, che io già ascoltavo prima che avessero successo. Con Massimo ho lavorato anche sul primo disco solista di Graziano Romani.